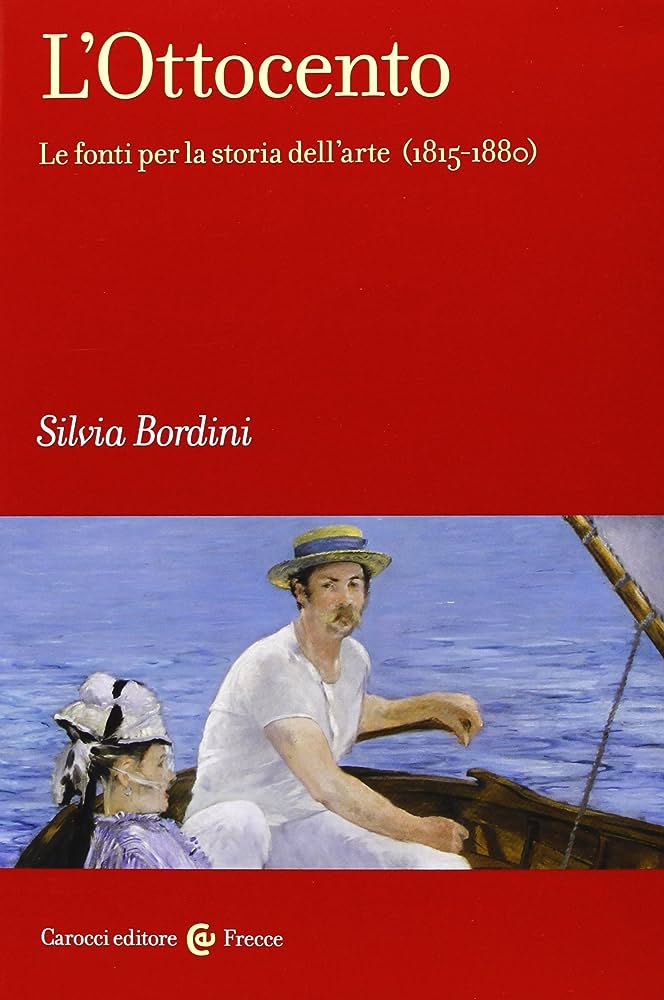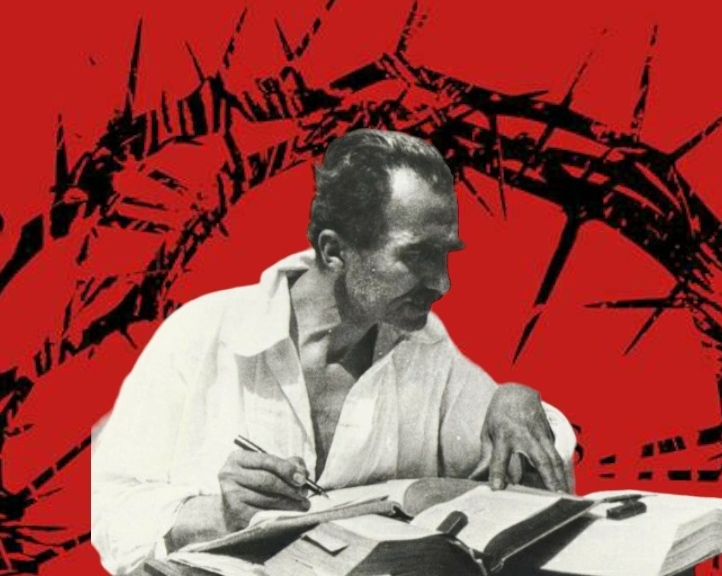L’Occidente “colpevole” e “vincente”. Parla Giacalone.

Di Francesco Subiaco
Guerrafondai, colonialisti, imperialisti, classisti, paternalisti in una parola: “colpevoli”. Colpevoli, dei crimini dei propri avi e di quelli che non riescono ad evitare dei loro contemporanei, di essere ricchi, di essere moderni, di essere democratici (ma anche di non esserlo abbastanza…). Ma soprattutto di essere “vincenti”. Macchiati di un nuovo peccato originale secolare, ogni giorno gli occidentali sono chiamati ad essere giudicati senza possibilità di replica per quei “crimini” compiuti al passato da loro o dai loro avi, che però vengono tanto difesi quando vengono declinati al presente dai loro avversari. Ma come è possibile che oggi l’Occidente sia vittima di questa fantasiosa inquisizione laica? E come si può superare questa religione della colpa? Ne parliamo con Davide Giacalone, saggista, direttore de La Ragione ed editorialista di RTL 102.5, vicepresidente della Fondazione Luigi Einaudi, che ha brillantemente risposto a queste domande nel suo ultimo saggio edito Rubbettino: “Colpevoli & vincenti. Gli occidentali contro sé stessi”. Un testo che analizza le nevrosi, le psicosi e i miti che attanagliano gli occidentali e che li pongono in uno stato di minorità autoindotta, creando un clima da “giudizio universale permanente”, in cui alla luce del terzomondismo, del mito autocratico, del pietismo e del woke, si pretende di giudicare e condannare la civiltà occidentale, in nome di colpe epocali, sempre condannate al passato, quanto giustificate al presente.
–Perché “Colpevoli e vincenti”?
“Colpevoli” perchè per buona parte del dibattito pubblico noi occidentali siamo colpevoli di tutto. Di quello che facciamo e di quello che facemmo (o, meglio, che fecero le nostre passate generazioni). Portiamo la colpa di quel che abbiamo prodotto, ma anche di quello che non riusciamo a evitare. Dal colonialismo alle guerre scatenate da altri che a detta di molti non sappiamo evitare. Siamo colpevoli per quel che contiamo, nel mondo, ma anche per quel che non contiamo. Siamo, quindi colpevoli perché vittima di un eurocentrismo capovolto. Infatti se prima gli occidentali si sono sentiti e raccontati come il centro della civiltà, che nell’Europa prima, e nell’Occidente poi, ha visto il motore principale della Storia (ignorando le altre civiltà che si sviluppavano parallelamente alla nostra…), poi gli occidentali si sono sentiti invece i colpevoli di ogni malefatta, di ogni crimine ed abuso.
-Di cosa siamo “colpevoli”?
Siamo “colpevoli” di ogni cosa: del colonialismo del passato, che viene evocato ogni volta per attaccare ed accusare l’occidente, mentre si sminuisce o si dimentica troppo spesso quello presente delle autocrazie; della schiavitù, diffusa già nel mondo antico, da popoli di diversa provenienza, dai romani agli egiziani, passando per molti popoli africani; delle guerre, soprattutto di quelle provocate da altri…
Siamo colpevoli perché “vincenti” e saremo perdenti perché vincenti. Secondo un modo di pensare che elimina la Ragione, ma affascina il pensiero di quanti non possono accettare che ci siano passi in avanti, giacché si dimostrerebbe solo che quei pensieri antidemocratici ed antioccidentali sono rimasti indietro, intimoriti, incapaci di fare i conti con la realtà. Siamo colpevoli anche di dubitare, di osservare criticamente tale autoflagellazione occidentale, siamo colpevoli del sentirci orgogliosamente cittadini della parte migliore del mondo, quella in cui i ricchi altrui corrono ad abitare e che i poveri altrui provano a raggiungere con ogni mezzo. Una colpevolezza che ci affligge anche perché per parlarne usiamo e useremo delle parole e le parole sono colpevoli, perché i colpevoli devono tacere e se proprio non riescono a farlo devono usare un linguaggio che interiorizzi la colpa, quindi cancelli le parole, le genufletta al pentimento per averle generate con culture del dominio. La nostra cultura è colpevole in quanto tale, in quanto anche solo si definisce tale, mentre si deve portare rispetto per le altre culture, comprenderne il “fondato”, “giusto” e “giustificabile” risentimento verso di noi. Peccato che, vaneggiando in questo modo, si commette il più atroce dei soprusi: si toglie umanità a queste altre culture, le si relega in un campo che, volendolo santificare, diventa il campo santo del pensare, in cui esistono solo culture morte e devitalizzate. Così facendo però si è veramente colpevoli ma di abolire le culture, le differenze, le libertà. La colpa è in sostanza l’altra parte della medaglia della conquista.
-E perché si è diffusa questa “apologia della colpa”?
Si è diffusa perché, in fondo, essa non è altro che la denigrazione, l’odio, la paura della libertà. Perché quest’ultima non si separa mai dalla responsabilità. E se crogiolarsi nelle colpe collettive ha l’indubbio pregio di non dovere mai pagarne le conseguenze, preferire evitare questo sciocco esercizio e dedicarsi a quello della libertà comporta l’indubbio prezzo di risponderne direttamente. Poi c’è un altro fattore.
–Quale?
Che il nostro Occidente ha al suo interno “gli occidentali contro se stessi”.
–Ovvero?
Una parte del nostro mondo e della nostra cultura disprezza ed odia l’Occidente perché odia la democrazia e la libertà, perché queste due componenti hanno una pessima compagna: la responsabilità. La fuga dalla libertà è una fuga dalla responsabilità verso un mondo in cui si può essere irresponsabili, innocenti solo perché si è sudditi. Per questo si tifa contro i nemici dell’Occidente perché così facendo si è dalla parte dei nemici della libertà, anche contro ogni logica. Pensiamo alla barbara invasione della Russia, contraria ad ogni convenzione internazionale o militare. Anche di fronte a questo crimine internazionale c’è chi ha accusato la Nato, gli Stati Uniti, l’Europa con vaneggiamenti su ipotetici accerchiamenti occidentali della Russia, smentiti anche dallo stesso Putin…
–Secondo lei come potrà l’Occidente uscire da questo stato di minorità autoindotta?
Riconoscendo che si tratta di uno stato di minorità apparente. Perché l’Occidente non è solo la parte del mondo in cui si vive meglio e più a lungo, ma perché è anche quella che sia a livello economico sia sotto il profilo delle libertà civili, è più avanzata. Siamo un mondo imperfetto, perché da noi non ci si sente liberi se tutti gli uomini non sono liberi e non si sente ricchi se tutti gli uomini non possono avere gli strumenti per realizzarsi materialmente. La civiltà occidentale ha una aspirazione universale alla libertà, alla democrazia, al dubbio che è la nostra vera forza e l’essenza del nostro modo di essere occidentali. Riscoprendo questa aspirazione potremmo superare questa condizione da lei descritta.
–Cosa ne pensa del politicamente corretto e del woke?
Io penso proprio che uno dei veri punti di debolezza dell’Occidente sia questa strana forma di ipocrisia interna portata dalla cancel culture e dal politicamente corretto. Una ipocrisia con sfumature anche molto demenziali in alcuni casi… Ad esempio, la stupidità di non poter dire “maschio” o “femmina” perché si rischia di poter offendere qualcuno parlando di “sesso di nascita” o “biologico”. Intendiamoci la libertà del nostro mondo è giustamente totale e ognuno può scegliere di intraprendere o un percorso di transizione e fare quello che vuole nella propria vita privata, e deve poter vedere difeso e garantito questo diritto. Ma pretendere di dare una definizione ad ogni cosa che ognuno ama fare nella propria vita sessuale o di attuare delle vere e proprie persecuzioni del vocabolario o della grammatica, mi sembra qualcosa di demenziale. La libertà e i diritti sono un’altra cosa…
–Che ne pensa della questione israeliana?
Israele anche se non fa parte dell’Occidente geografico, fa sicuramente parte dell’Occidente storico. Come diceva Ugo La Malfa, la libertà dell’Occidente si difende sotto le mura di Gerusalemme. Una frase che mi sembra attuale oggi più che mai. Israele è, infatti, una grande democrazia occidentale assediata da una organizzazione terroristica come Hamas. Ma occorre precisare un fattore: Hamas è un organizzazione terroristica, che non si batte per i palestinesi ma che usa i cadaveri e la miseria dei palestinesi per bloccare quei processi di pace e convivenza. Del resto la striscia di Gaza è tornata a essere un problema non quando gli israeliani la consegnarono ai palestinesi, ma quando Hamas fece fuori l’Anp(Autorità Nazionale palestinese ndr.). Che oggi non conta più niente. È da quando Hamas vinse le elezioni, grazie ai soldi che riceveva dai nemici occidentali, che Gaza è divenuta una rampa di lancio – continuo – per missili contro Israele. Contro questa furia fanatica approcci ragionevoli e aiuti sono stati neutralizzati dal delirio terrorista. Occorre ribadire quindi che Israele è un bastione della libertà occidentale, come l’Ucraina è una trincea della sicurezza occidentale. Né Israele né l’Ucraina sono la perfezione, perché la perfezione è impossibile, se non nei deliri totalitari. Ma l’attacco a Israele e all’Ucraina viene dai nemici del nostro mondo. Ed è contro di essi che bisogna rispondere. Perché questi sono i nemici della libertà e della democrazia.